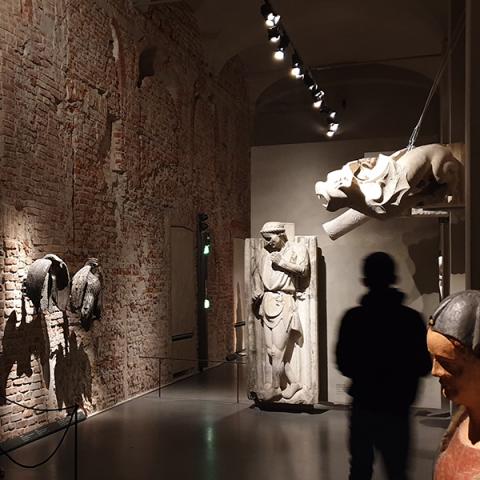MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO di recuperoeconservazione_magazine
Professore Ordinario fr di Restauro nel Dipartimento di Architettura di Ferrara. In precedenza ha svolto una lunga attività di architetto presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze, dove ha auto modo di progettre e dirigere molti interventi di restauro, tra i quali la Cupola brunelleschiana di S.M. del Fiore, il Duomo di Prato, il Corridore medievale di Prato, la Loggia dei Lanzi a Firenze. È autore di studi sulla storia della tutela sui caratteri morfologici e tipologici della città storica, su approfondimenti di natura teorica, oltre che su singoli interventi.